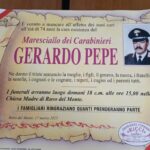Quando l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l’epidemia e la patologia Covid-19 era configurabile come una pandemia, qualcosa d’inedito, dirompente, autenticamente straordinario si è concretizzato improvvisamente nella vita di quasi 8 miliardi di persone, in tutto il globo. E nonostante un lockdown totale, il distanziamento sociale comunque il virus si è diffuso in tutto il mondo, mandando in tilt i si sistemi sanitari e i servizi per l’infanzia e l’adolescenza.
Tutta la popolazione ha risentito del Covid 19, persone anziane nelle loro case e\o nelle RSA, non hanno potuto vedere i figli e i nipoti per tantissimi mesi, persone in difficoltà economica o senzatetto si sono trovati ancora più soli e senza aiuto, per la chiusura dei luoghi di accoglienza, gli ammalati che si sono visti bloccare cure indispensabili. In generale c’è stato un vero sconvolgimento nel quotidiano di ognuno.
Se prendiamo in considerazione l bambini e gli adolescenti è innegabile che hanno sofferto, a due anni dall ‘inizio della crisi causata dal Covid-19, perché è stata preclusa la vita quotidiana fatta di riti quali andare a scuola, uscire per incontrarsi con i loro amici, viaggiare, ecc, tutti comportamenti importanti nella loro formazione psicologica e sociale. Per gli adolescenti il lockdown è piombato proprio nel momento in cui cominciavano a sperimentare insieme ai loro coetanei nuove forme di stare insieme, fare gruppo, misurarsi con altri che non erano i genitori.
La scuola in DAD , è stata uno svantaggio per tutti ma soprattutto per bambini ed adolescenti che avevano una situazione precaria in casa per abitazioni, per reddito, con il rischio di arrivare ad una dispersione scolastica notevole.
Molti di questi ragazzi e ragazze che frequentavano strutture sociali, (spesso Associazioni di volontariato o simili), in cui erano accolti nei momenti extra scolastici ed extra familiari e nelle quali avevano punti di riferimento positivi per la loro crescita, hanno visto precluse queste opportunità per molto tempo, con il rischio di non essere più in grado di ritornare ad una vita normale e di lasciare la scuola.
I cambiamenti così drastici e prolungati in persone giovani hanno portato ovviamente delle conseguenze che si sono evidenziate dopo alcuni mesi e che si sono prolungate nel tempo.
Alcuni dati di una ricerca relativa a 1143 genitori di bambini di età compresa tra 3 e 18 anni, includente famiglie italiane ha documentato come l’85.7% dei genitori abbia percepito dei cambiamenti dello stato emotivo dei propri figli durante la quarantena, inquadrabili nell’ambito della difficoltà di con-centrazione (76.6%), noia (52%), irritabilità (39%), irrequietezza (38.8%), nervosismo (38%), sensazione di solitudine (31.3%), disagio (30.4%) e preoccupazione (30.1%) .
I bambini e gli adolescenti hanno sofferto di ansia, specialmente nella prima parte della pandemia e poi di stress. Ansia per il pericolo costante che coglievano in famiglia e fuori, paura di ammalarsi o che si ammalino i genitori, paura che la situazione non torni più come prima. La depressione deriva soprattutto dall’isolamento in cui la pandemia ha costretto i ragazzi e si evidenzia soprattutto in quelli più grandi. Questa situazione ha portato un aumento di ricoveri nei reparti di Neurologia e Neuropsichiatria Infantile di ragazzi giovanissimi e purtroppo un aumento di suicidi o tentati suicidi. I neuropsichiatri infantili hanno chiesto che si ricostituiscano o si creino reti di cura dedicate ai giovani e alle loro esigenze, in riferimento soprattutto alle regioni meridionali. Il “bonus psicologo” servirà almeno in parte a questo scopo se porterà personale specializzato nei Dipartimenti.
Non stupisce quindi che la crisi pandemica abbia risvegliato una attenzione nuova per la condizione delle giovani generazioni nella nostra società e soprattutto per i suoi sviluppi futuri
E mentre i vaccini e le misure introdotte hanno mitigato gli effetti più gravi della pandemia dal punto di vista sanitario, forte è l’incognita rispetto alle ripercussioni sociali nella crisi pandemica e alla effettiva resilienza che saremo in grado di introdurre come società.
Il Next GenerationEU. può essere un’opportunità con la speranza che le politiche pubbliche a favore dei giovani non siano più soltanto un obiettivo “orizzontale” del Piano, cioè un aspetto da considerare nel raggiungimento di altri obiettivi portanti,
ma diventino presupposto e priorità assoluta
Le aree tematiche strutturali di intervento che sono
- Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile
- Istruzione e Ricerca
- Inclusione e Coesione
- Salute
devono. tenere conto della priorità attribuita dalle istituzioni europee alle politiche giovanili.
Se si vuole uno sviluppo veramente resiliente al centro del Piano e per ogni specifica tematica, non potranno che esserci i giovani e il loro futuro.
Dott.ssa Marilena Blasucci